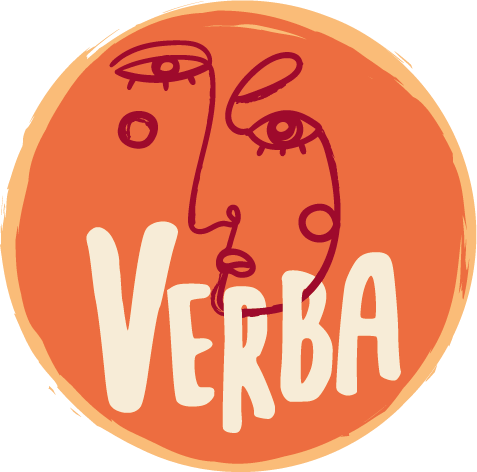Di Coryse Farina Bouvet
Il binomio psicoterapia e disabilità è uno dei più ovvi e riconosciuti, ma solo quando ad essere disabili sono ə pazienti! Non esiste, infatti, nell’immaginario collettivo che lo/la psicoterapeuta sia disabile. Nell’ambito di una relazione di aiuto, la persona con disabilità è sempre considerata come quella che riceve aiuto, mai come il/la professionista che può supportare e sostenere. Abbiamo incontrato Alessandra Zerbinati psicoanalista ipovedente: qual è stata la sua esperienza?

Ciao Alessandra Zerbinati, innanzitutto grazie per la sua disponibilità e per il tempo che ci ha dedicato in questa intervista. Condividere una prospettiva così unica sulla pratica della psicoanalisi da parte di una psicanalista ipovedente come lei è un’opportunità che offre profondi spunti di riflessione.
Passiamo subito al dunque con le domande:
Ci parli di lei e del suo percorso di studi: cosa l’ha portata a scegliere di diventare psicoanalista?
Grazie mille a voi e allo spazio che mi state dedicando. Sì, allora, mi chiamo Alessandra Zerbinati e sono nata nel 1956. Fin da giovane, ho coltivato il sogno di diventare medico, intraprendendo un percorso di specializzazione in microchirurgia.
All’età di 33 anni però, mi hanno diagnosticato la sindrome di Stargardt, una malattia caratterizzata da perdita progressiva della visione centrale associata a chiazze maculari e perimaculari. Inizialmente l’ho presa bene. Diciamo che era meglio di tante altre malattie, tant’è che, decisa a continuare la mia carriera di medico, sono passata dalla microchirurgia a dedicarmi all’ambito dentistico. Tuttavia, col passare del tempo notando un ulteriore declino della vista, ho cominciato a considerare la psicologia come una possibile via.
Detto con molta sincerità, desideravo rimanere in campo medico, quindi l’unica possibilità rimasta in quanto ipovedente era la psicoterapia. Al tempo riuscivo ancora a leggere quindi ho intrapreso un percorso di studi per diventare psicanalista. Ovviamente l’interesse e la passione per questa disciplina c’erano, ma si sono sviluppati e concretizzati solo una volta iniziato il percorso.
Sono dunque diventata psicanalista ed ho esercitato questa professione fino al 2014 quando l’ipovedenza ha preso la meglio. L’assicurazione non mi copriva più quindi sono andata in pensione anticipata per invalidità a 58 anni.
Ad oggi quindi, non posso più leggere né guidare, però cammino e riesco a muovermi abbastanza bene rispetto a chi è cieco totale.
Entrando nel dettaglio della sua professione, in quanto psicoanalista ipovedente qual era la reazione dei suoi/ delle sue pazienti quando comunicava la sua situazione?
Allora, la regola base è quella di informare subito il paziente del proprio limite.
Durante il primo colloquio quindi parlavo della mia ipovedenza. Li informavo che non avrei potuto leggere referti medici, diari o lettere e che non avrei potuto riconoscere determinate espressioni. Questo ha comportato reazioni diverse: alcunə pazienti non l’hanno accettato.
Ricordo di una paziente che mi ha detto chiaramente “Guardi mi dispiace, ma non continuo perché lei mi fa pena”. Ma d’altronde era quello che io chiedevo loro. Io stessa chiedevo un rapporto sincero, di fiducia, e quindi era normale che se un paziente provasse pena per un terapeuta non poteva in alcun modo sentirsi supportato dallo stesso. Per cui alcunə hanno rinunciato e lə ho inviatə da colleghə di cui mi fidavo. Altrə invece mi hanno subito detto “Sì, sembra un problema ma ha l’aria di essere una persona competente quindi preferirei continuare”. Lasciavo insomma decidere a loro se continuare.
Pensa che la disabilità abbia influenzato in qualche modo il transfert?
Il transfert no, anche perché avvertendo subito il/la paziente della situazione, con quellə che decidevano di continuare si stringeva una sorta di alleanza terapeutica. Loro sapevano già che determinati stati d’animo che io non potevo vedere dalla mimica dovevano essermi espressi e descritti a voce, quindi si instaurava una complicità molto forte. Ovviamente, se non c’è questa alleanza e complicità, il non poter cogliere la mimica in psicoterapia è un grosso limite al transfert.
Ha utilizzato nel corso degli anni delle tecniche terapeutiche particolari? Se sì, quali?
Per quella che è la mia esperienza di psicoanalista ipovedente posso dire che non ce ne sono di particolari. Quel che è certo è che in ogni nuovo percorso c’è bisogno di un grande adattamento da entrambe le parti e che la chiarezza fin da subito è l’arma vincente per un percorso terapeutico efficace.
Al primo approccio chiaro, si aggiungono poi strategie alternative di comunicazione da utilizzare nel tempo come appunto la richiesta di una descrizione della mimica, l’espressione orale di sentimenti ed emozioni, ma anche il registrare su un supporto elettronico come un cellulare alcuni stimoli elaborati durante la settimana piuttosto che scriverli su un diario, oppure banalmente il fatto di precisare e ricordare allə pazienti che se lə incontro per strada e non lə saluto è perché non lə vedo e non perché non voglio salutarlə.
Ma sono tutte dinamiche accettate generalmente con facilità.
Ha avuto pazienti ciechi? Le sedute erano diverse?
Si, quando capitavano pazienti ciechi o ipovedenti ai miei colleghi spesso venivano mandati da me, o per lo meno facevo io i colloqui introduttivi.
Le sedute erano assolutamente uguali a tutte le altre fatte con persone vedenti, ma sicuramente in quanto psicoanalista ipovedente c’era una comprensione della problematica più profonda.
Che consigli daresti a tuttə i tuoi.tue colleghə vedenti che accolgono persone cieche o con disabilità ?
Di trattarle esattamente come se vedessero. Trattarle come se non avessero una disabilità, ma accogliendo ovviamente la sofferenza qualora ci fosse. Mi spiego, ogni volta che unə paziente esprime un disagio, una difficoltà, un malessere, un senso di inferiorità legato alla sua disabilità, il/la terapeuta ha il compito di accoglierlo e aiutarlo a superarlo; altrimenti deve essere trattato come tuttə gli/le altrə.
Il/la terapeuta può inoltre dare consigli pratici, offrire strumenti, suggerire delle associazioni a cui rivolgersi come A.P.R.I., invitare il/la paziente a partecipare alle attività e ai percorsi di riabilitazione, oppure spingerlə a incontrare persone con trascorsi simili al fine di creare comunità e sentirsi più compresi. Insomma, le cose sono tante.
Ci sono cambiamenti nell’ambito della psicologia accessibile che ti auspichi?
La tecnologia ha cambiato la vita di tuttə, e quindi anche quella dellə terapeutə.
Un uso maggiore di slide, l’audiodescrizione, le app che descrivono l’ambiente in cui si è in tutti i suoi particolari e i visi delle persone che si incontrano, oppure strumenti come le sintesi vocali etc hanno sicuramente rivoluzionato questa pratica. In questo senso quindi non posso che sperare che le tecnologie siano sempre più potenti al punto da abbattere completamente le barriere che una ipovedenza / cecità può innalzare.
C’è un momento della sua carriera che reputa significativo ?
In realtà mi vengono in mente più momenti, tutti legati alle intense relazioni con i/le mieə pazienti. Trattandosi di lunghi percorsi di psicoanalisi, la cui gran parte dura oltre quattro anni, si crea un transfert talmente solido da potersi considerare quasi famiglia.
Il rapporto si “confondeva”, nel senso che l’alleanza terapeutica era talmente forte che i/le pazienti quasi dimenticavano o davano per scontato il fatto che fossi ipovedente. E questa è una sensazione molto bella e significativa, perché voleva dire che ero riuscita a creare una complicità al di là del ruolo.
E voi, andreste da unə terapeuta ipovedente?
Fatecelo sapere inviandoci un messaggio alle pagine Facebook e Instagram dell’Associazione!